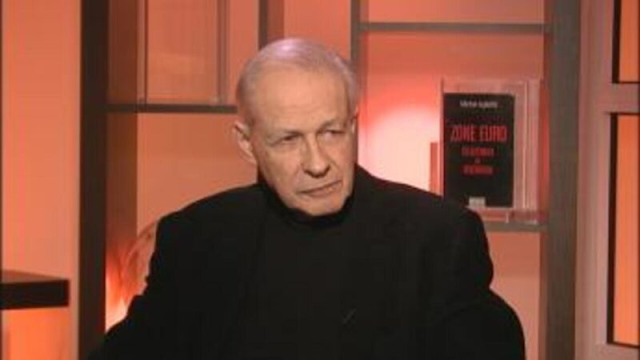- Andrea Fumagalli e Stefano Lucarelli -
E così se ne è andato anche Michel Aglietta, a 87 anni, un altro degli scienziati sociali che più hanno segnato la nostra formazione. E' stato in particolare un esperto di economia monetaria internazionale e ha studiato la relazione tra la struttura dei sistemi finanziari e la crescita economica
Diplomato all’École polytechnique nel 1959, la sua sensibilità e il suo interesse per gli aspetti teorici del dibattito politico lo portano a scegliere l’ENSAE come scuola di formazione nel 1961.
Nell’ottobre 1974, Michel Aglietta ha difeso la sua tesi di dottorato all’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, intitolata Régulation du mode de production capitaliste dans la longue période. Prendendo come esempio gli Stati Uniti (1870-1970). La commissione di laurea era composta da Raymond Barre, Hubert Brochier, Carlo Benetti, Joseph Weiller e Edmond Malinvaud.
Ha ricevuto l’agrégation (concorso pubblico nel sistema educativo francese) in economia nel 1976, primo passo per intraprendere la carriera accademica. Dopo aver conseguito il dottorato, Michel Aglietta ha tenuto seminari all’INSEE. Vengono discussi i sette capitoli della sua tesi. Ogni mese si tiene un incontro su uno dei capitoli. Si forma un gruppo di persone, tra cui Robert Boyer e Alain Lipietz, Pascal Petit provenienti dall’INSEE, dal CEPREMAP e dalle università. Sulla base di questi incontri, Aglietta scrisse il libro: Régulation et crises du capitalisme, Calmann-Lévy, 1976. Quando uscì, il libro ottenne una certa visibilità e fu tradotto abbastanza rapidamente in inglese (per Verso, Londra, 1979). Fu il battesimo della scuola francese della regolazione, che fu soprattutto portata avanti grazie al lavoro di Boyer, Lipietz, Coriat, Nadel e Petit. Aglietta ne fu l’ispiratore principale anche se non ha mai fatto parte del suo gruppo di ricerca. Di Aglietta, in italiano, sono stati tradotti solo due scritti: la postfazione alla terza edizione di Régulation et Crises du capitalisme nel 2001, accompagnata da un saggio sui compiti dello Stato di Giorgio Lunghini (Bollati Boringhieri), e Il dollaro e dopo: la fine delle monete chiave con una introduzione di Carlo Dadda, nel 1988 (Sansoni).
Dopo aver superato l’agrégation, Aglietta fu nominato professore all’Università di Amiens. Vi rimase fino al 1982, quando si trasferì all’Università di Parigi Nanterre, dove rimase fino alla pensione. Negli anni Ottanta ha insegnato anche all’Institut d’études politiques de Paris.
Oltre all’attività accademica, Michel Aglietta ha condotto ricerche presso il Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) e in vari organismi monetari e finanziari. È stato consulente della Banque de France, visiting fellow presso il dipartimento di ricerca della Federal Reserve Bank di New York nel 1995, consulente della Compagnie parisienne de réescompte e poi di Groupama Asset Management, una filiale di Groupama. Dalla fine degli anni ‘70 si è interessato alla teoria e alla storia della moneta e all’economia internazionale nell’ambito degli studi condotti presso il CEPII per comprendere le cause e le conseguenze della globalizzazione finanziaria.
Aglietta è stato senza ombra di dubbio un grandissimo economista; influenzato dallo strutturalismo althusseriano e dalla rilettura francese di Keynes, insieme ad André Orléan, è stato autore di testi eccellenti sulla teoria della moneta, costruiti sugli studi antropologici di René Girard (La violence de la monnaie del 1982, La monnaie souveraine del 1998, il primo edito da PUF, il secondo da Odile Jacob).
La gran parte delle teorie economiche moderne tende a ridurre il capitalismo al mercato. La teoria della regolazione vede invece nella forma concorrenziale solo una delle forme istituzionali che regolano il funzionamento di un’economia capitalistica. Accanto ad essa si annoverano il regime monetario, la struttura del rapporto salariale, la forma dello Stato e la forma di adesione a un regime internazionale. Se queste cinque forme istituzionali raggiungono una compatibilità sostenibile, si crea un modo di regolazione, un equilibrio istituzionale che dura finché dura.
La teoria della regolazione – che riesce a spiegare molto bene la crisi del fordismo e meno bene i regimi di accumulazione successivi ad esso – rifiuta, così, l’individualismo metodologico che porta ad analizzare gli equilibri economici a partire dal comportamento razionale dei singoli agenti, e punta a una logica sistemica, in cui i comportamenti dei singoli sono influenzati dalle dinamiche macroeconomiche e istituzionali.
Aglietta è stato in particolare un esperto di economia monetaria internazionale e ha studiato la relazione tra la struttura dei sistemi finanziari e la crescita economica. La liberalizzazione finanziaria iniziata negli anni Ottanta è stata vista come un mezzo per migliorare l’efficienza dei mercati finanziari a livello globale (la concorrenza avrebbe dovuto portare a un’allocazione ottimale del capitale e a una diminuzione dei tassi di interesse) e, in ultima analisi, alla crescita. Per Aglietta, però, la transizione verso un’economia finanziaria globalizzata è accompagnata da instabilità ciclica e rischio sistemico. Così si esprime nel suo Macroéconomie financière (V edizione, 2008):
“Il capitalismo passa di bolla in bolla. La sua evoluzione è costellata di crisi finanziarie. È diventato completamente globale. La finanza è il fluido che collega i diversi tipi di capitalismo in un’unica economia globale. Sostiene una crescita potente, ma propaga le crisi”.
L’attività speculativa comporta dei rischi che non garantiscono sempre un ritorno in termini di plusvalenze e questa situazione, attraverso il contagio (o effetto mimetico), porta a una crisi finanziaria generalizzata. Affinché la mobilità dei capitali sia davvero al servizio dell’economia reale, Aglietta insiste sulla necessità di introdurre nuove regole, rafforzare il controllo prudenziale dei mercati e attuare politiche anticicliche più attive.
Una intervista del 2018[1] può aiutare a comprendere la grande intelligenza e originalità di Michel Aglietta. Gli viene chiesto: perché la moneta internazionale è ancora un enigma per la maggior parte degli economisti?
La sua pronta risposta aiuta anche a comprendere il disordine internazionale in cui stiamo vivendo e in cui crescono le tensioni militari fra Paesi:
“Perché non esiste. Se seguiamo la nostra logica, non c’è moneta se non c’è sovranità, quindi non c’è moneta internazionale se non c’è un sovrano universale. … Se tutte le nazioni decidessero di trasformare il FMI in una banca centrale, che fosse la banca centrale delle banche centrali, che possa emettere liquidità specifica che non fosse il debito di nessuna delle nazioni partecipanti, queste nazioni avrebbero creato qualcosa di simile a ciò che esiste nell’eurozona.
Oggi questo non esiste. Ci sono solo valute nazionali. Quale ordine può sostituire l’assenza di una moneta internazionale in un mondo globalizzato in cui il capitale circola? Se i capitali non circolassero, il problema non si porrebbe: i controlli sui capitali manterrebbero le valute separate.
Tuttavia, se si vuole che la globalizzazione abbia luogo, è necessario organizzarla. Nel XIX secolo, il gold standard era un modo per affrontare la questione della moneta internazionale, anche se la convertibilità dell’oro rimaneva sotto il controllo delle nazioni. Esse istituirono la convertibilità dell’oro per le loro valute e si impegnarono a rispettarla. Si trattava di una sorta di costituzione monetaria universale non scritta. Un’altra configurazione era il sistema di Bretton Woods, un sistema monetario istituzionalizzato da un accordo internazionale che stabiliva la preponderanza di una valuta, il dollaro, nel quadro di un insieme di regole e procedure comuni amministrate da un’istituzione internazionale, il FMI. I controlli sui capitali hanno permesso a questo accordo internazionale di funzionare, perché ha preservato una sufficiente autonomia monetaria per le nazioni. Con il crollo del sistema di Bretton Woods, tutte le regole monetarie internazionali sono scomparse. Le relazioni monetarie sono diventate direttamente dipendenti dagli scambi di liquidità sui mercati dei cambi, e quindi da instabili compromessi privati che si riflettono nelle fluttuazioni dei tassi di cambio. Perché nelle relazioni fra privati si elegge come riferimento una moneta piuttosto che un’altra, una moneta nazionale che le altre nazioni accetteranno? Stiamo entrando nel campo dell’egemonia e della geopolitica.”
Ma le categorie concettuali introdotte in Régulation et Crises du capitalisme sono state fondamentali anche per il pensiero critico a noi caro: negli anni Ottanta cominciò un dialogo tra giovani neo-operaisti italiani e regolazionisti presso il CEPREMAP. Quel dialogo portò alla stesura di un lavoro di Beppo Cocco e Carlo Vercellone, “Le rapport salarial fordiste en Italie” (1988), discusso da Benjamin Coriat e Yann Moulier, alla presenza anche di Toni Negri. Quel confronto condusse poi a uno speciale sulla regolazione per Futur Antérieur (coordinato da Farida Sebaï e Carlo Vercellone) : École de la régulation et critique de la raison économiste (1994), dove si può leggere una lunga intervista a Michel Aglietta. Lungo quella strada si saldarono sodalizi intellettuali e letture conflittualiste del nucleo analitico regolazionista, che portarono all’entusiasmante lavoro collettivo sul capitalismo cognitivo, al libro seminale curato da Carlo Vercellone Sommes nous sortis du capitalisme industriel? (La Dispute, 1993), e agli atti di un convegno svoltosi nell’ottobre 1998 all’Universitè di Amiens (dove aveva anche insegnato Michel Aglietta) pubblicati in un libro a cura di Christian Azais, Antonella Corsani, Patrick Dieuaide dal titolo Vers un capitalisme cognitif. Entre mutation du travail et territoires, (L’Harmattan, 2001). Poi la storia dei movimenti fece il resto….
Bibliografia orientativa (in ordine cronologico)
Aglietta, M. (1976). Régulation et crises du capitalisme, Calmann-Lévy.
Aglietta, M., & Orléan, A. (1982). La violence de la monnaie. Presses Universitaires de France.
Aglietta, M. (1988). Il dollaro e dopo : la fine delle monete chiave. Sansoni.
Cocco, G. & Vercellone, C. (1988) . Le rapport salarial fordiste en Italie: une mise en perspective historique. Cahiers du GERTTD et du CEPREMAP.
Sebai, F. & Vercellone, C., a cura di, (1994), École de la régulation et critique de la raison économique, Éditions l’Harmattan, (Futur Antérieur).
Aglietta, M., & Orléan, A. (1998). La monnaie souveraine. Odile Jacob.
Aglietta, M., & Lunghini, G. (2001). Sul capitalismo contemporaneo. Bollati Boringhieri.
Azais, C., Corsani, A., Dieuaide, P., a cura di, (2001). Vers un capitalisme cognitif. Entre mutation du travail et territoires. L’Harmattan.
Vercellone, C., a cura di, (2003). Sommes nous sortis du capitalisme industriel? La Dispute.
Aglietta, M., & Rebérioux, A. (2004). Dérives du capitalisme financier. Albin Michel.
Aglietta, M. (2008). Macroéconomie financière. V ed., La Découverte.
Fumagalli, A. & Lucarelli, S. (2008), La finestra di fronte. La théorie de la régulation vista dall’Italia, Quaderni di Dipartimento – EPMQ, No. 201, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi
Aglietta, M., & Valla, N. (2021). Le futur de la monnaie. Odile Jacob.
NOTE
[1] L’intera intervista in francese, condotta da Adrien Faudot e pubblicata su Interventions économiques / Papers in Political Economy, può essere letta a questo link